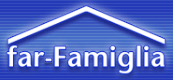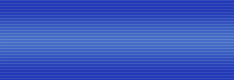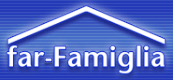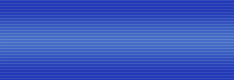08/12/2008
Restauro della Madonna del Cardellino
Torna all'attenzione del mondo, dopo un restauro di dieci anni, la «Madonna del cardellino» di Raffaello Sanzio, esposta dal 23 novembre al 1 maggio a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi. Essa è il fulcro della mostra intitolata «L'amore, l'arte e la grazia – Raffaello: la Madonna del cardellino restaurata». L'esposizione, curata da Marco Ciatti e da Antonio Natali, direttore della Galleria degli Uffizi, alle cui collezioni l'opera appartiene, approfondisce la complessità di un intervento che per lungo tempo si era ritenuto impossibile. Anche attraverso supporti multimediali il visitatore può così immergersi nel cuore del recupero di un'icona del nostro rinascimento. Senza trascurare, oltre al dato tecnico, l'inquadramento storico artistico. Sono infatti esposte insieme alla «Madonna del cardellino» quattro opere coeve, per evitare quello che Natali ama definire l'effetto feticcio e per proporre un'inedita attribuzione al primo che restaurò la tavola raffaellesca, che qui si indica come Ridolfo del Ghirlandaio. In mostra accompagnano la «Madonna del cardellino» un ritratto ascritto agli anni fiorentini di Raffaello (1504-1508), la «Gravida», per testimoniare la seconda tipologia di opere a cui l'artista si dedicava a Firenze insieme alle Madonne; c'è anche un altro ritratto, la «Monaca», verosimilmente di Ridolfo del Ghirlandaio, figlio di Domenico, amico e coetaneo di Raffaello. Quindi una «coperta» decorata a grottesche, talora attribuita a Raffaello, ma presumibilmente di Ridolfo, forse proprio coperta per la «Monaca», ulteriore testimonianza della consonanza di questo artista coi modi dell'urbinate. Infine una terracotta invetriata di Girolamo della Robbia che ripropone la composizione della «Bella Giardiniera» di Raffaello, attualmente conservata al Louvre. Dipinto che Raffaello lasciò incompiuto e che, secondo un'antica tradizione, fu completato da Ridolfo.
Il restauro della «Madonna del cardellino» si deve ai laboratori dell'Opificio delle pietre dure di Firenze.
In quest’opera, Raffaello risente ancora della lezione del Perugino, ma soprattutto acquisisce quella di Leonardo, non solo nella composizione piramidale delle figure, ma soprattutto nello sfumato del paesaggio che proprio il restauro, assieme ai particolari del prato, ha portato a nuova intellegibilità. Dipinta per Lorenzo Nasi, ricco mercante fiorentino con cui Raffaello era entrato in amicizia durante il suo soggiorno nel capoluogo toscano, lo narra Vasari nelle «Vite», il 17 novembre 1547 (1548, secondo l'anno fiorentino) la tavola subì danni gravissimi a seguito del crollo della casa di Nasi, rovinata in uno smottamento collinare. Fu immediatamente riassemblata, recuperata e unificata nella superficie pittorica. In virtù dell'amicizia e della vicinanza stilistica, si propone in mostra che questo intervento sia dovuto a Ridolfo del Ghirlandaio.
|